In un saggio del 2012 ho raccontato come il jazz sia diventato un insegnamento ufficiale dei Conservatori italiani partendo da Frosinone. Fu l’occasione per ricordare musicisti, direttori e appassionati che hanno fatto della provincia ciociara una delle grandi capitali del jazz, e dove ogni anno, ad Atina, si celebra uno dei suoi festival più prestigiosi. Ma tutto cominciò dalle visioni di alcuni visionari, Daniele Paris, Gerardo Jacoucci, Vittorio Fortuna. Ripubblico qui il mio scritto, senza ritoccarlo o aggiornarlo. E rileggendolo mi pare che parli del jazz con una tecnica jazzistica, mille fili che si intrecciano in tante variazioni.
Una buona metà degli iscritti al nuovo ordinamento del Conservatorio di Frosinone frequenta il corso di musica jazz; è un successo che dipende ovviamente dalla qualità dell’insegnamento e dal prestigio dei professori, guidati da Ettore Fioravanti, batterista leader di diversi gruppi, nonché componente del quintetto di Paolo Fresu di cui fa parte fin dalla costituzione quasi trenta anni fa. Un musicista che a me sembra tra i pochi che riesca a dare una sorta di autonoma musicalità al suo strumento, mentre negli altri suoi colleghi risulta quasi sempre in funzione caudataria rispetto al resto del complesso: so bene che è un’impressione da profano, ma non deve essere del tutto gratuita se qualcosa di analogo ha detto di lui un altro grande jazzista Marcello Rosa, maestro del trombone jazz in Italia che nella sua lunga carriera ha suonato con miti come Milt Jackson e Lionel Hampton, per dire che è uno che se ne intende.
Ma c’è anche un’altra ragione che porta studenti di ogni parte del paese a imparare il jazz al Licinio Refice, ed è la sua storia, è la storia dell’insegnamento del jazz in Italia con la quale il Conservatorio di Frosinone c’entra davvero molto. li primo tentativo di introdurre l’insegnamento di jazz in un conservatorio ci fu, infatti, al principio degli anni settanta del scorso secolo, a Roma, al Santa Cecilia. L’idea venne al direttore dell’epoca Renato Fasano che affidò l’incarico di tenere i corsi a Giorgio Gaslini, un musicista geniale che già una quindicina di anni prima aveva provato qualcosa di analogo alla Scuola civica musicale di Milano, dando vita a quello che viene ancora oggi ricordato come il momento della svolta, quando il jazz, che nel nostro paese aveva avuto il suo vero momento di lancio nel secondo dopoguerra sotto l’influenza della musica arrivata al seguito delle truppe americane, varcò i confini dell’accademia sfidando le perplessità e il vero e proprio ostracismo dei custodi della tradizione musicale italiana, quella che nei conservatori si tramandava, cristallizzata nei programmi del 1930. Di quelle lezioni romane dovrebbe esserci ancora traccia visiva negli archivi della televisione pubblica, perché esse vennero riprese in una trasmissione chiamata, con la diretta semplicità che oggi è spesso sostituita dall’allusività, qualche volta incomprensibile, altre volte addirittura greve dei titoli, Jazz in Conservatorio. Chi l’ha vista ha ancora nella memoria la sigla iniziale in cui la telecamera inquadra le scale dell’antico istituto gremite di giovani, vestiti negli abiti dalle fogge che allora dovevano apparire anticonformiste e oggi ci sembrano appena delle sbavature della grigia eleganza degli spezzati in uso tra glli studenti universitari, come appaiono anche in una foto celebre di pochi anni prima: quella di ragazzi in tumulto davanti alla facoltà di lettere di Roma immortalati un attimo prima che uno di loro, Paolo Rossi, precipitasse dalla scalinata diventando con quella morte, la cui accidentalità parve quasi sollecitata dalla storia, il primo simbolo della contestazione studentesca che sarebbe dilagata, anche da noi, subito dopo. L’esperimento di Santa Cecilia ebbe successo, ma ciò non gli servì a durare oltre i due anni che separarono il maestro Fasano dal suo pensionamento, il successore Jacopo Napoli, infatti, adducendo a ragione la scarsità di aule – circostanza che se fosse ritenuta ostativa porterebbe ancora adesso a cancellare metà delle lezioni di qualsiasi strumento nei conservatori – abrogò il corso e riportò il jazz fuori dalle mura dell’istituzione. Ecco perché, dunque, il conservatorio di Santa Cecilia non può fregiarsi dei meriti di quell’importante innovazione, essendosi in fin dei conti limitato a suggerirla quasi spaventandosi immediatamente dopo della spericolatezza dell’idea.
È a questo punto che nella storia entra in scena il Conservatorio di Frosinone il cui direttore Daniele Paris invece non si lasciò affatto spaventare dalla prospettiva di battere un sentiero nuovo, raccogliendo il testimone lasciato cadere dai supponenti maestri del Santa Cecilia. Egli si mosse però tenendo bene a mente una regoletta suggeritagli dall’esperienza, e anche dalla saggia concretezza di cui aveva già dato prova mettendo su dal niente e in pochi anni il suo conservatorio, e cioè che ogni novità per essere meno incerta deve essere sigillata, nel nostro paese, da un qualche imprimatur statale; riuscì così a ottenere un’autorizzazione ministeriale per svolgere in Ciociaria quello che non si era stati capaci, a dispetto della splendida premessa, di realizzare a Roma: un corso di jazz, che pur non rilasciando titoli specifici risultasse, però, incardinato nell’attività ufficiale del conservatorio, sollevato quindi dalla preoccupazione che la mancanza di spazi congiurasse a minacciarne la sopravvivenza. Il primo titolare italiano di una cattedra jazz si ebbe dunque a Frosinone, Paris lo individuò con l’occhio di chi sa riconoscere ciò che le persone hanno dentro e aspettano solo qualcuno che li aiuti a metterlo fuori. La scelta cadde su Gerardo Jacoucci, insegnante di solfeggio ma anche pianista e arrangiatore di Modugno e Josephine Baker, nativo di Veroli, una bella cittadina arroccata su un colle ma la cui campagna scende fino ai confini con la quasi pianeggiante Frosinone, conosciuta sia per essere stata la patria delle balie ciociare ambite dalle madri della nobiltà romana per nutrire di latte sostanzioso i loro figli, sia per aver ospitato, ai suoi tempi, Giuseppe Gioachino Belli in un soggiorno di cura e convalescenza, di cui egli lasciò testimonianza in un epistolario raccolto poi, da uno dei suoi massimi conoscitori, lo storico e critico Marcello Teodonio, sotto il titolo, tratto da una delle lettere, “Nelle terre degli antropofagi“. Gerardo Jacoucci, insieme con Giorgio Gaslini e Ettore Ballotta, un altro dei pionieri con una cattedra assegnatagli per insegnare jazz al Conservatorio di Bologna, ma prudentemente camuffata sotto il nome meno impegnativo di “musica d’uso”, fu l’autore del programma triennale di jazz che il ministero autorizzò per tutti i Conservatori e che può perciò considerarsi l’atto definitivo con cui il nuovo corso si affrancò dalla sua condizione incerta nell’ambito del sistema ufficiale dello studio della musica; un passaggio fondamentale al quale risultarono preziose le esperienze e le riflessioni maturate nel Conservatorio di Frosinone, che, dunque, da allora è una delle punte avanzate nell’insegnamento di questa disciplina.

Di questo inizio mi ha parlato a lungo Paolo Tombolesi, noto e apprezzato pianista jazz, che oggi insegna tecnica dell’improvvisazione al Licinio Refice, dopo esserne stato studente per un tempo reso lunghissimo dalle vicissitudini legislative che hanno accompagnato la piena assunzione del jazz nell’olimpo delle discipline meritevoli d’essere insegnate e apprese in un Istituto pubblico di formazione. È un cammino che per Paolo, e chi sa quanti come lui, prende avvio trenta anni fa, raggiunge un primo traguardo con un attestato dall’incerto valore legale, che viene subito dopo necessariamente seguito dal “vero” diploma di pianoforte, e che poi riprende quando il corso, negli anni novanta, da sperimentale diventa regolamentare e si incanala nel grande solco dell’ordinamento vigente, anche se mantiene la caratteristica dell’insegnante unico, che sta a sottolineare la persistenza di una sorta di suo status minoritario, provvisto di un’identità che gli accademici e diffidenti controllori dei programmi ministeriali continuano a pensare possa completarsi solo indirettamente, come paragrafo aggiuntivo al resto delle discipline; Paolo perciò prende il suo nuovo e regolare diploma di jazz, ma non può fermarsi perché, alla fine del decennio, la riforma cambia di nuovo, e questa volta per tutti, le regole e il subentrato nuovo ordinamento, articolato in un triennio e un biennio, ammette lo studio della musica al livello universitario, con titoli finali equiparati alla laurea, fissando però in dieci anni il periodo di transizione da un sistema all’altro, al termine del quale – e siamo arrivati ai giorni nostri – l’esperimento si traduce in norma, il jazz con i nuovi programmi conquista la parità, giusto quaranta anni dopo le lezioni di Gaslini. Quando sono diventato presidente del Conservatorio, ho incontrato Paolo nel consiglio di amministrazione, a rappresentare gli studenti pur non avendone più l’età e soprattutto le necessità di formazione; lo conoscevo già come concertista di fama ma ne avevo seguito da lontano le prime esibizioni, anche per l’amicizia politica, che per alcuni anni fu intensa, con il padre Luigi, socialista e cattolico, direttore didattico che dirigeva la sua scuola secondo il modello comunitario che Adriano Olivetti aveva reso reale nella sua Ivrea e che sparuti gruppi di utopisti concreti come lui si sforzavano ancora, un decennio dopo, di attuare in altri borghi meno fortunati del paese. Di quei tempi, ricordo un giovanile concerto di Paolo ad Alatri, su una strada che si slarga in uno spiazzo posto alla curva che apre alla fuga del rettilineo voluto dal podestà degli anni del fascismo per dare respiro, sventrando i vicoli che lo impedivano, alla piazza principale, ma anche per riportare nelle dimensioni ridotte del paese le prospettive ammirate nella città fatale, dopo la sistemazione dei Fori imperiali o la costruzione di via della Conciliazione. Un quartetto di giovani jazzisti intratteneva su un palco, mentre il pomeriggio estivo si spegneva nella sera, un centinaio di persone, e confuso in questa piccola folla, c’era il padre di Paolo che ascoltava il figlio suonare, con un bel sorriso di soddisfazione impresso sul viso stemperatosi poi, al momento di incrociare inaspettatamente il mio sguardo, in quello che mi parve un cenno di scusa, quasi a giustificarsi di aver lasciato trapelare un sentimento da salvaguardare con più cura nell’intimità, la soddisfazione di un padre che sa di dover trattare con pudore i suoi affetti. L’amore per il jazz Paolo lo fa risalire all’abitudine di trattenersi nella grande sala, al pianoterra dell’edificio che ospitava provvisoriamente alcune sezioni del conservatorio, dove gli ensemble facevano le loro prove. Il direttore Paris aveva deciso che queste prove dovevano essere aperte a tutti, e Paolo sfruttando la vicinanza della fermata dell’autobus che lo avrebbe riportato al suo paese, nei tempi morti dell’attesa si immedesimava nelle improvvisazioni dei grandi jazzisti che erano i docenti dell’istituto, spesso applicati in discipline più canoniche, come il pianista già allora di fama internazionale Enrico Pieranunzi e, prima di lui, il sassofonista Baldo Maestri e il pianista Roberto Pregadio, al quale oltre trenta anni appresso avremmo dedicato, poco prima che morisse, nel chiostro del nostro Conservatorio, una serata nella quale vollero suonare tutti i docenti del dipartimento jazz per rendergli gli onori riconosciuti non alla star televisiva che era diventato ma a un caposcuola.
“Tecniche di improvvisazione musicale” sembra una disciplina propria del jazz, il modo di insegnare un metodo capace di alzare un argine, o di consegnare una traccia e dei criteri, a creazioni altrimenti troppo anarchiche. I nuovi ordinamenti, però, la riferiscono a tutti i generi; ricordano che l’improvvisazione è stato il passato di tutte le musiche e che solo con l’affermarsi delle orchestre, la dittatura delle partiture e della sacralità dell’autore, la specializzazione della divisione del lavoro, insinuatasi in tutti i fiumi e rivoli dell’attività umana, non solo in quella industriale, essa è stata rinnegata e si è spenta nella pratica dei concerti, mentre – mi racconta Paolo – ancora nei programmi di sala del primo recital pianistico di Listz compare una variazione su temi proposti dal pubblico e Ferruccio Busoni, alla fine dell’ottocento, riteneva non disdicevole al suo rango di grande pianista provarsi alla stessa maniera. L’equivoco perdura, perché si alimenta della divaricazione novecentesca tra una musica che è disposta a concedere solo interpretazioni ma non innovazioni o variazioni oltre una strettissima soglia di flessibilità, e un’altra musica che per essersi fondata programmaticamente su una sua specie di autorigenerazione continua, sollecitata da svariati apporti etnici e culturali e accesa da tutte le suggestioni sonore, ha accettato per decenni un suo destino di minorità, dal quale non tutti sono ancora disposti ad ammettere l’avvenuto riscatto. Nel jazz non ci sono partiture precostituite, il concerto non è mai l’esecuzione di un testo definitivo, ma il tentativo di trovare, partendo da un canovaccio più o meno articolato, qualche melodia che il musicista può usare per estendere il brano originario o per insinuare una chiave di interpretazione che, seguita fino dove può condurla l’energia che vi è depositata dentro, può dare esiti inattesi. Il jazz non è, in un certo senso, il regno della necessità ma quello della serendipità, della scoperta determinata dall’occasione, della disponibilità a essere guidati dall’imprevisto. Ettore Fioravanti lo scrive, presentandosi sul suo sito web e parlando delle batterie ma non credo sia improprio riferirlo anche agli altri jazzisti e a tutti gli strumenti, che l’essenza della poetica del jazz è conciliare la linearità melodica con il tessuto modulare dell’improvvisazione, far cantare i tamburi, crear parole con i piatti, tendere l’anima, un’esperienza che noi potremmo intendere come una specie di confronto, estenuato fino al dispetto, tra i sentimenti, i pensieri, i desideri e la musica condotto finché si avverte che oltre non si può andare e si smette, dandosi un altro appuntamento per proseguire la sfida con tutta l’oscurità e la gioia che abbiamo dentro.
In uno dei concerti di chiusura della stagione estiva dell’anno accademico, che si tengono all’aperto in uno spazio coperto su un lato del quale montiamo un palco e di fronte ospitiamo il pubblico, seduto in una platea che continua con una gradinata capace di accogliere alcune centinaia di persone, abbiamo ospitato Danilo Rea, studente per un paio di anni a Frosinone prima di trasferirsi a Roma, dove si sarebbe diplomato. Danilo, al pianoforte, senza accompagnamenti, ha suonato, in una serata in cui è sembrato che tutta la città avesse scoperto una sua incontenibile passione per il jazz, alcune sue rielaborazioni tratte da arie del grande melodramma o di grandi canzoni italiane, ammaliando tutti con le scoperte a cui si può arrivare catturando una linea melodica, un elemento stilistico e sottoponendolo a questa originale fermentazione che distilla altro senso o rinnova quelli sopiti dall’abuso dell’ascolto. Non saprei dire altro, in un discorso che è sostenuto solo da impressioni o poco più; mi torna, però, in mente una lezione a me più congeniale, che mi venne data dal critico letterario con il quale mi sono laureato, Walter Pedullà, allievo prediletto di Giacomo De Benedetti un maestro che non ho conosciuto direttamente ma i cui saggi, affascinanti per la tremenda umanità che sapevano evocare anche dalla letteratura all’apparenza più neutra, ho letto negli anni in cui le buone letture segnano di più. Pedullà suggeriva di arrivare alla conoscenza di un testo aprendolo con la propria scrittura, mimandone le movenze stilistiche, afferrandone cioè un lembo per tirarlo fino a passare per quella smagliatura che presto o tardi si sarebbe rivelata. È il suono che fa il pifferaio magico che riesce a portare dietro di sé i roditori stanandoli dalle viscere del proprio paese, o il rito dello sciamano che guarisce i malati cercando con il suo violino o il tamburello la nota giusta, risolutiva, quella che, come nelle tarantolate di San Paolo a Galatina raccontate da Ernesto De Martino, sa ricomporre l’animo lacerato e ricostruire l’identità cancellata dalle catastrofi personali o della storia. Sensazioni di questo tipo ho provato quando, su consiglio di Paolo che mi spiegava le tecniche dell’improvvisazione, senza costringermi ad una per me improponibile scalata delle vette degli algoritmi musicali, ho cercato e trovato su youtube, che da un po’ è diventato la risposta immediata alle mie curiosità musicali, i concerti di Massimo Urbani, il jazzista romano che sbalordì coetanei e maestri prima di finire ammazzato da un’overdose che gli sarebbe dovuta servire a placare l’inquietudine da cui si sentiva posseduto. In un documentario, molto bello, che filma alcune sue grandi interpretazioni di classici dentro una fabbrica abbandonata, ho risentito questa tensione della musica, che cerca nella variazione ripetuta qualcosa che restituisca un senso alla personalità devastata dell’uomo; ho capito che l’improvvisazione del jazz, sottoposta sempre alla minaccia del virtuosismo alla quale però non è detto debba per forza soccombere, ha poco a che fare con la tecnica e c’entra molto invece con la missione che da sempre affidiamo alla musica, quella di ricucire i nostri sentimenti oppure, bruciandone i brandelli, di scoprirne la falsità per liberarcene e aprirci così nuove prospettive del mondo.
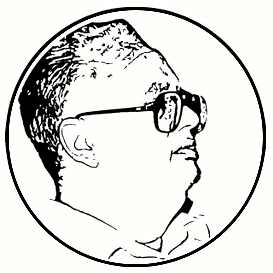
Con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento il jazz dei conservatori si è preso una sua clamorosa rivincita; le materie che prima erano attribuite a un solo docente hanno acquisito ciascuna una loro autonomia, ogni strumento è diventato singola materia di insegnamento costringendo a una moltiplicazione delle cattedre e alla chiamata massiccia di numerosi docenti esterni. Molti conservatori, optando per una scelta di basso profilo e con l’occhio rivolto alle sempre più rigide compatibilità di bilancio, hanno ridotto al minimo gli effetti, accorpando le cattedre sulla base di una certa libertà di scelta resa possibile dalle direttive tutt’altro che perentorie della direzione generale. Al Conservatorio di Frosinone abbiamo voluto diversamente, per non impoverire i nostri corsi proprio nel momento in cui la grande emarginazione è arrivata alla fine. Abbiamo pensato anche che l’autorizzazione a emettere titoli di studio legali concessa ad alcune istituzioni private di gran prestigio avrebbe potuto far scemare l’attrazione per i nostri corsi. Ancora di più, però, è contato il ricordo del tempo dei pionieri, quando il grande Conservatorio di Santa Cecilia non ebbe il coraggio di fare quello che avrebbe fatto un giovane conservatorio della provincia italiana, entrando di diritto nella storia del jazz, come gli avrebbe con cordialità riconosciuto rispondendo a un omaggio dei nostri studenti il grande Ornette Coleman, arrivato dalle nostre parti a un festival di jazz importante, quello che si svolge nel mese di agosto di ogni anno ad Atina, ideato sul finire degli anni ottanta da Vittorio Fortuna, un avvocato socialista mio amico troppo presto scomparso, con il quale ho condiviso tante speranze politiche e suggestioni intellettuali. Paolo e suo padre, il jazz ad Alatri, il festival di Atina e Vittorio Fortuna, io presidente di conservatorio nel momento dell’affermazione accademica del jazz: ogni cosa si illumina dell’altra e c’è un filo segreto che le tiene insieme.
(Da “Conservatorio. Ieri Oggi Domani”, Ediesse, 2012 pp. 69-79).

